Home /
Scienza partecipata: molte forme, un solo obiettivo
La nostra esperienza parte nel 2015 con il progetto europeo iSPEX, che coinvolgeva cittadini nella misurazione dello spessore ottico atmosferico per stimare la presenza di particolato sospeso. Quel primo passo segnò l’idea che cittadini informati potevano contribuire in modo concreto alla produzione di dati ambientali.
Con lo scandalo Dieselgate accelerammo la nostra attività: nel 2016 nacque la campagna NO₂ NO Grazie, in cui migliaia di cittadini installano campionatori passivi di NO₂ nelle loro città, misurando l’inquinamento urbano prodotto principalmente dal traffico. Dati che non restano solo nelle mani degli esperti, ma diventano strumenti concreti per politiche pubbliche.
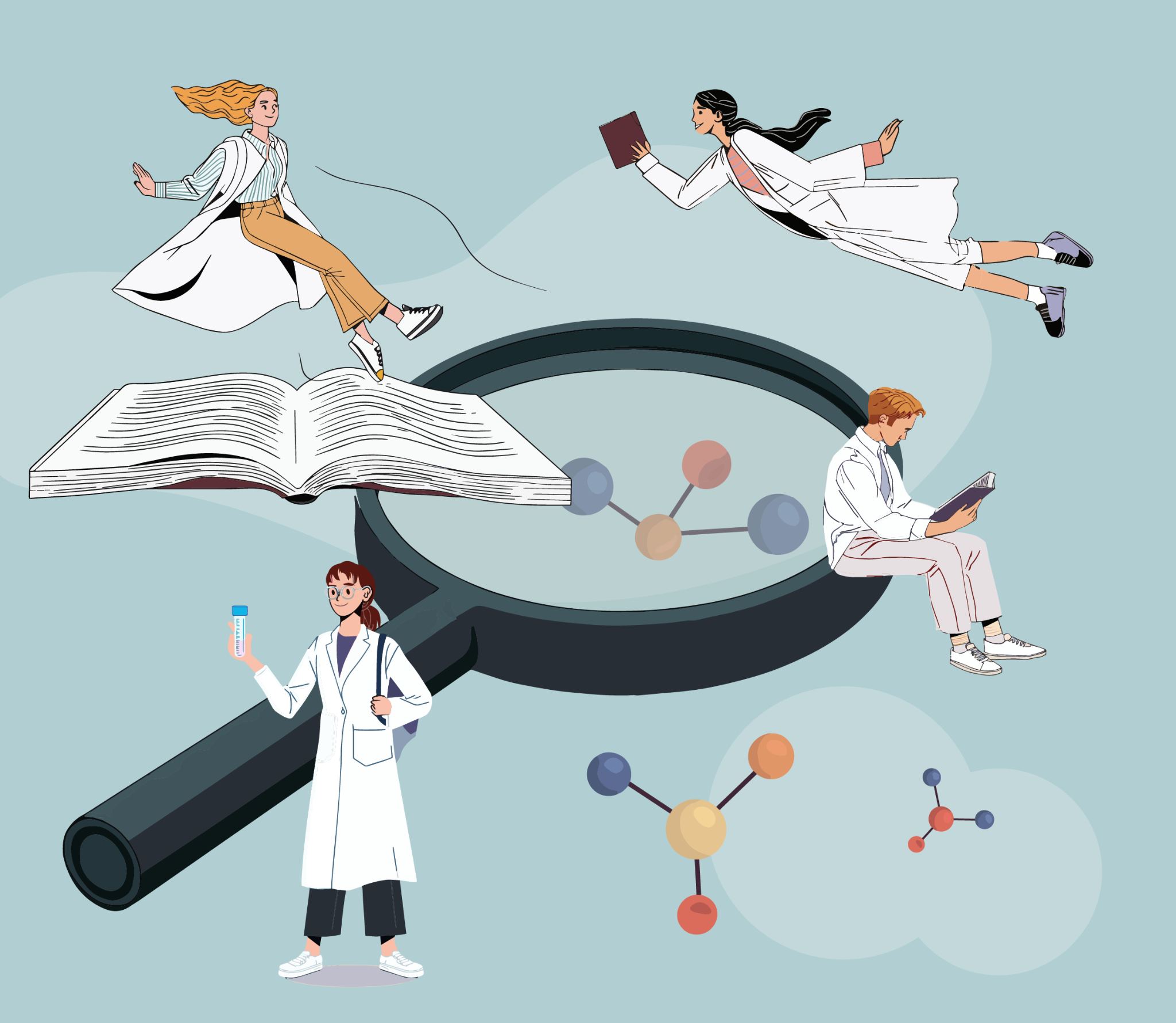
Le forme della partecipazione
La scienza partecipata può assumere modalità diverse, tutte utili e complementari:
- Monitoraggi diffusi con sensori passivi
Come nei progetti NO₂ NO Grazie, in cui cittadini collocano dispositivi per periodi definiti, contribuendo alla raccolta capillare di dati su NO₂. - Campagne estemporanee con strumenti scientifici portatili
Realizzate in collaborazione con università o enti di ricerca, permettono di effettuare rilievi puntuali in zone critiche. - Bioindicatori come i licheni
Utilizzati per analizzare la qualità dell’aria in modo biologico, attraverso la presenza e lo stato di salute di specie sensibili all’inquinamento. - Coinvolgimento delle comunità locali
Il ruolo attivo di cittadini, famiglie, scuole e comitati è centrale per raccogliere dati e interpretare i risultati insieme agli esperti.
Esperienze recenti: città portuali e progetti locali
Città portuali mediterranee
Attraverso la campagna “Facciamo respirare il Mediterraneo”, abbiamo monitorato le emissioni da traffico marittimo nelle città portuali, rivelando livelli di NO₂ significativamente elevati nelle aree portuali rispetto a quelle interne. Le misurazioni hanno coinvolto città italiane, spagnole, greche e portoghesi, dimostrando l’urgenza di regole più stringenti per le emissioni navali.
(link alle pagine delle notizie in merito ?)
Olbia: studenti in campo per l’aria
Nel 2024, a Olbia, studenti delle scuole superiori hanno partecipato a un progetto nell’ambito del programma MEZZO (1/2), misurando per un mese le concentrazioni di NO₂ in tutta la città. I risultati hanno mostrato un’aria relativamente meno inquinata rispetto alle grandi città, ma con alcune aree critiche vicino alle strade principali. L’iniziativa ha incluso momenti di confronto con i ricercatori, analisi dei dati e interpretazione pubblica, dimostrando il valore educativo e scientifico dell’iniziativa.
(link al progetto – esterno)
Impatti sulla salute e sulle politiche
I dati raccolti nelle campagne sono elaborati attraverso modelli di regressione spaziale (LURF) e incrociati con informazioni sanitarie e urbanistiche. Sono stati utilizzati per:
- Identificare hotspot urbani di NO₂, ad esempio vicino alle scuole.
- Informare studi sanitari, come quelli realizzati da ATS Milano.
- Supportare la creazione di Zone a Traffico Limitato, come a Milano (Area B) e Roma.
L’affidabilità dei dati è garantita grazie a collaborazioni scientifiche con università, epidemiologi e modellatori ambientali.
L’attendibilità scientifica: validazione, collaborazione accademica e uso istituzionale dei dati
Un elemento centrale della nostra attività è assicurare che i dati prodotti con la citizen science siano scientificamente robusti, validi, utili per decisioni politiche e per studi di salute. Ecco in sintesi come lo realizziamo, ma puoi scoprire di più grazie alla nostra guida:
1. Validazione con centraline di riferimento
- Nelle campagne NO₂ NO Grazie usiamo campionatori passivi (fiale assorbenti) che sono esposti per un mese in posizioni selezionate.
- Per verificare l’accuratezza, abbiamo affiancato ai campionatori passivi le centraline fisse delle varie ARPA, per confrontare direttamente le misure mensili. I risultati mostrano una buona correlazione: seppure le misure passive non offrano dettagli orari, esse catturano bene la variabilità spaziale su macrozone cittadine.
2. Collaborazione con università e ricerca
- Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità) e il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio hanno realizzato da ultimo, usando i dati NO₂ NO Grazie del 2023, uno studio che quantifica gli effetti attesi dell’istituzione di strade scolastiche. Lo studio, pubblicato su Environmental Research, stima che queste misure possano ridurre le concentrazioni medie mensili di NO₂ del 6% con punte fino al 20% in alcune scuole.
- Collaborazioni con Dipartimenti universitari (Chimica, Epidemiologia, Scienze Cliniche) garantiscono che le analisi, le mappe modellistiche, le stime di rischio sanitario risultino metodologicamente trasparenti, con peer review, protocolli standard, analisi delle fonti d’errore e omogeneità dei processi.
3. Modelli spaziali e stime sanitarie
- I dati misurati non bastano da soli per coprire ogni punto della città; per questo utilizziamo modelli spaziali complessi, in particolare modelli di Land Use Random Forest (LURF). Questi modelli sono “addestrati” usando i dati partecipati e altri indicatori territoriali (uso del suolo, traffico, densità urbana).
- Con le mappe ottenute dal modello LURF, possiamo stimare la concentrazione di NO₂ in punti non direttamente monitorati e identificare gli hotspot urbani. Questo rende le mappe più utili per le decisioni su mobilità, ZTL, scuole e misure di mitigazione.
- Non solo, ma è possibile valutare anche l’impatto sanitario sulla base delle concentrazioni monitorate e stimate: abbiamo stimato che a Milano circa 1.500 decessi l’anno potrebbero essere attribuiti all’esposizione cronica a NO₂ oltre soglie dannose, con le mappe e i modelli come strumento per quantificare rischi sanitari su scala cittadina.
4. Utilizzo istituzionale: ATS Milano e politiche pubbliche
- I dati generati dalle campagne NO₂ NO Grazie sono stati utilizzati da ATS Milano nei report sulla qualità dell’aria e salute.
- Le autorità locali, come il Comune di Milano, hanno adottato i risultati come base informativa per politiche quali Area B, strade scolastiche, e valutazioni locali di interventi sul traffico e mobilità. Ciò dimostra che i dati non restano solo nell’ambito accademico, ma tradotti in decisioni concrete.
Conclusione: perché i dati partecipati sono affidabili (e necessari)
Grazie a:
- approcci di validazione con strumenti ufficiali (centraline ARPA)
- collaborazioni scientifiche con università ed enti di ricerca
- uso di modelli spaziali consolidati come LURF
- pubblicazioni su riviste scientifiche peer‑reviewed
- uso effettivo da parte di istituzioni sanitarie e amministrazioni locali
…possiamo affermare che i dati di NO₂ NO Grazie sono affidabili, utili per la ricerca e per le politiche, e non semplici segnalazioni qualitative.
Un esempio europeo
NO₂ NO Grazie è anche stato riconosciuto anche dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) come esempio di buona pratica europea in materia di scienza partecipata applicata alla qualità dell’aria. La campagna è oggi parte di una rete di esperienze condivise, ed è inclusa tra le iniziative di riferimento per l’attuazione di politiche ambientali più trasparenti e inclusive.
E tu, cosa puoi fare?
La scienza partecipata ha senso solo se coinvolge persone reali. Puoi:
- Esplorare i risultati delle campagne precedenti nella tua città.
- Consultare le mappe interattive di NO₂ in Italia e nel Mediterraneo.
- Scoprire le singole campagne attive, i territori coinvolti e le date previste.
- Iscriverti alla prossima edizione di NO₂ NO Grazie o ad altri progetti attivi.
Inizia da qui → Scopri la campagna NO₂ NO Grazie
Consulta la mappa → Visualizza le mappe interattive
La qualità dell’aria che respiriamo è un bene comune. Contribuire alla sua conoscenza è un atto di cittadinanza scientifica.